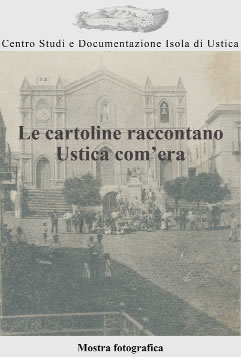Foto Emigrazioni Usticesi
La Famiglia Lauricella dalla California a Ustica 2005
La Famiglia Lauricella dalla California a Ustica 2005
Una prerogativa comune agli emigranti è il desiderio del ritorno. Gli usticesi , in quanto isolani, forse hanno più spiccata la nostalgia della terra natia perché, si sa, l’isola suscita un più forte legame con i propri abitanti. Questo desiderio struggente del ritorno lo han tramandato di generazione in generazione e lo si riscontra dal numero dei discendenti che dagli States e dalla fFrancia ritornano sull’isola. Nel 2005 venticinque membri della famiglia Lauricella sono giunti dalla California alla ricerca delle proprie origini a Ustica e a Lipari e così anche nel 2011 un altro gruppo dalla Francia. (AV)
Cfr. Longo Jean-Claude, Insula mater, in «Lettera» n. 38-39, pp. 8-12
Ailaar Vito, Grazie Claudia, in «Letetra» n. 38-39, 2011, pp. 13-14
Cfr. Virgets Ronnie, Postacard fronm Ustica, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp.16-24
Virgets Ronnie, Cartolina da Ustica, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp.16-24
(EM_005)
Emigranti usticesi in Algeria
Emigranti usticesi in Algeria
Oltre alle Americhe altra meta degli emigranti furono la Tunisia e l’Algeria specie nei primi del Novecento. Commercianti, artigiani, pescatori e contadini del meridione italiano venero richiamati da promesse allettanti di lavoro. Erano i tempi del forte rilancio delle colonie in terra d’Africa e agli emigranti viene concessa la nazionalità francese. Conseguita l’indipendenza delle colonie molti degli oriundi usticesi si trasferirono in Francia. Lo studio di questo filone emigratorio è in corso, grazie a Roland Licciardi che sta riallacciando rapporti tra gli originari usticesi che vivono in Francia. (AV)
Cfr. Licciardi Roland, De Ustica à Guyotville (Algérie), in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42
Cfr. Licciardi Roland, Da Ustica à Guyotville (Algeria), in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42
Cfr. Licciardi Roland, From Ustica to Guyotville, in «Lettera» n. 21-22, 2006 p. 35-42
Cfr. Longo Jean-Claude, Insula mater, in «Lettera» n. 38-39, pp. 8-12
(EM_0004)
Ultima partenza per New Orleans 1966
Ultima partenza per New Orleans 1966
L’ultima emigrante partita da Ustica per New Orleans è stata Rosa Mancuso, richiamata dallo zio. A New Orleans troverà l’amica Maria Bertucci Compagno che la introdurrà nella vasta comunità di oriundi usticesi. Secondo una indagine condotta da Chris Caravella nell’area di New Orleans sono insediati circa 70.000 cittadini originari di Ustica. Il calcolo è stato effettuato con rigore scientifico partendo dall’accertamento dei 1.329 cognomi usticesi che figurano nell’elenco telefonico di New Orleans. La vastità del fenomeno emigratorio usticese è testimoniata anche dal fatto che gli abitanti di Ustica che nel 1849 erano 4.548 si sono ridotti a 1.792 unità nel 1795 e a 1195 nel 1921. (AV)
Cfr. Guccione Cristina, Il fenomeno emigratorio del XIX e XX secolo dall’Italia verso l’America, in «Lettera» n. 30-31, 2009, pp. 1-15
Cfr. Caravella Chris, How many Usticesi in New Orleans?, in «Lettera» n. 5, 2000 p. 22
Cfr. Caravella Chris, Quanti Usticesi in New Orleans?, in «Lettera» n. 5, 2000 p. 23
di Cristina Guccione
(EM_003)
SS Montebello
SS Montebello
Il piroscafo Montebello è uno dei piroscafi che tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento adibiti al collegamento diretto di Palermo con New Orleans. Tra il 1861 e il 1879 sulla stessa linea erano adibiti i brigantini Elisabetta, il brigantino Catarina, Cinque Sorelle, soppiantati dai piroscafi S.S. Herham (battente bandiera inglese), Califonia, Manila, Mosselia, Liguria e Vincenzo Florio, che operarono nel anni successivi sino al 1904. Vennero tutti utilizzati da Usticesi. (AV)
Cfr. Ricerche di Shirley Barbara Nichols in copia presso questo Centro Studi
(EM_0002)
Gli emigranti di Angelo Tommasi 1895
Gli emigranti di Angelo Tommasi 1895
Gli emigranti del pittore Angelo Tommasi sintetizza con molta efficacia il fenomeno migratorio che ha caratterizzato la seconda metà dell’Ottocento postunitario. La moltitudine di barche a vela e la folla di emigranti bene esprimono, nel dipinto, la vastità del fenomeno: intere famiglie o gruppi di uomini, umile gente macerata da una vita di stenti, con la malinconia sul viso e la speranza nel cuore, si apprestano al grande viaggio che durava almeno 15 giorni in condizioni molto disagiate, se non inumane. La banchina è gremita di contadine, commercianti e artigiani che cercano di riposarsi; una contadina pensosa si sorregge il capo con la mano, altre allattano o, incinte, accarezzano dolcemente il grembo.
Il dipinto è collocato nella Galleria di Arte Moderna di Roma. (AV)
(EM_0001)