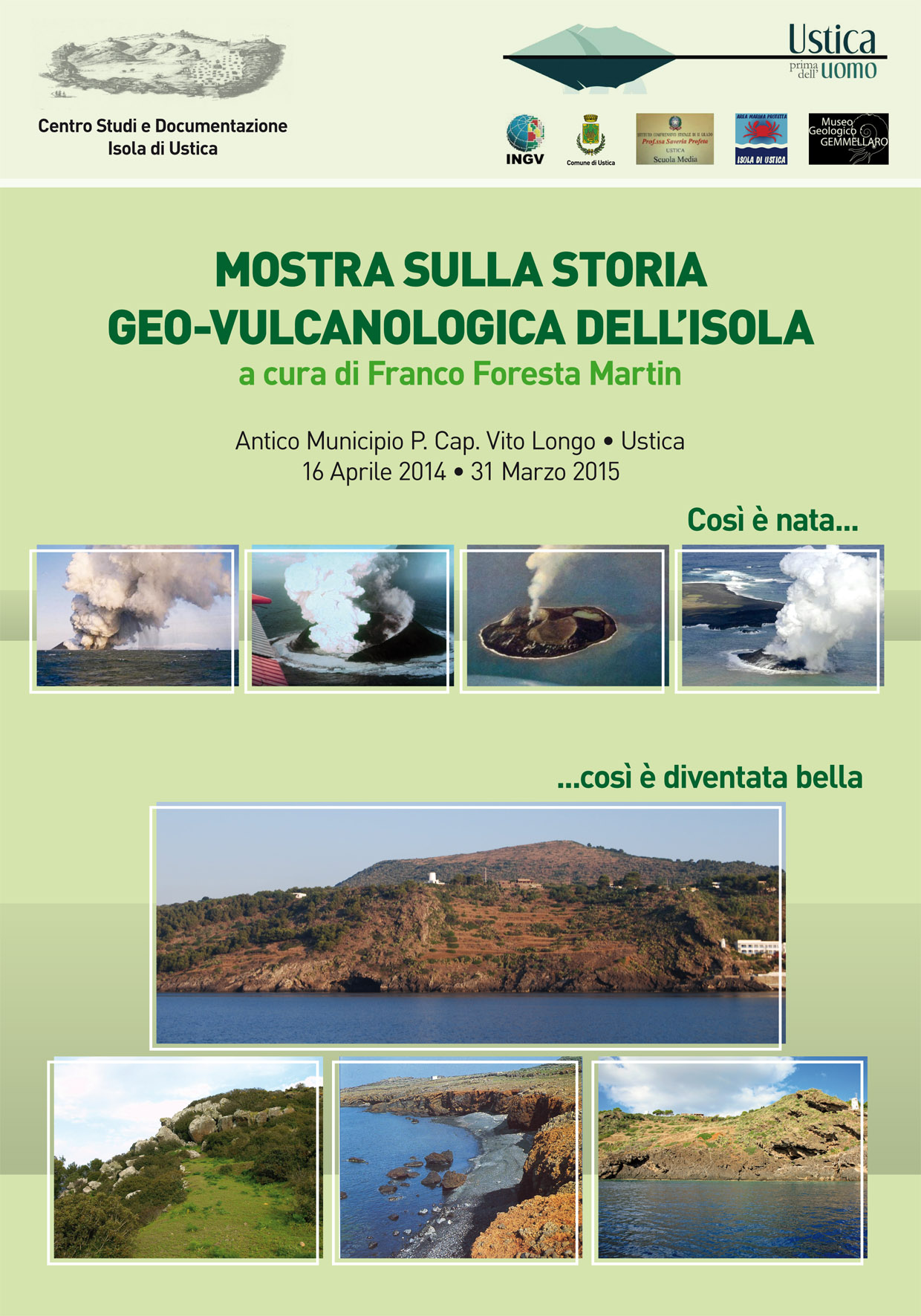Fototeca Ambiente
Punta Erbe Bianche
Punta Erbe Bianche
Passo della Madonna
Passo della Madonna
“Rinvennero…una immagine della Vergine con Gesù morto nelle braccia, il che diede il nome al cosiddetto Passo della madonna, ove i fedeli eressero poi una piccola cappella”. Così scrive il Tranchina nella sua storia di Ustica.
Il termine “Passo” indica il piccolo viottolo, stretto e a strapiombo sulla cala, che un tempo collegava la contrada di Tramontana alla contrada Spalmatore.
Su questo luogo va citata una legenda tramandata dal Pitrè:
«Sopra un picco della montagna di Ustica, corrispondente all'attuale Passo della Madonna, sorgeva una volta una statua di Maria. Ora, al tempo che i barbareschi infestavano l’isola, un galeone di pirati approdò in quel posto per una delle solite scorrerie. Scesi i marinai e veduta la statua cominciarono a deriderla e di prenderla a bersaglio delle loro schioppettate. Ma al primo colpo tirato da uno di loro, la palla, ributtata, tornò come fulmine indietro, cadendo sul legno che colò immediatamente a fondo convertendosi in uno scoglio. Questo scoglio è comunemente inteso "lu bastimentu turcu", perché conserva la forma del galeone, sprofondato e piegato da un lato. A pochi passi ve n’è un altro molto più piccolo, che pare ed è ritenuto la sua lancia, pietrificata pur essa».
Falco pellegrino
Falco pellegrino
Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è un rapace carnivoro lungo 34-46 (la femmina raggiunge i 58 cm), con peso di gr. 500-750 (la femmina il doppio). Riferisce il Tranchina che Doderlein ne ha individuato una coppia nidificante nella parete a strapiombo dell’Omo Morto «dal cui nido un ardito giovinetto, calandosi con funi, suole estrarre ogni estate i novelli pulcini per venderli o per mangiarli». Anche il prof. Bruno Massa ne segnala una coppia che attualmente nidifica nella stessa parete.
Cfr. Massa Bruno, Importanza dell’isola di Ustica per gli uccelli migratori, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9 Massa Bruno, The importance of the Island of Ustica for Migratory Birds, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9
Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, p. 5.
(NA_0004)
Cernia bruna
Cernia bruna
La cernia bruna (Epinephelus marginatus), conosciuta anche come cernia di scoglio, ha vita lunga fino a 50 anni e crescita lenta, ed è un pesce ermafrodita. Gli esemplari più giovani sono quasi esclusivamente femmine, mentre una volta superata la taglia di 9 kg cambia sesso.
è un pesce a cui è legata buona parte della storia recente dell’isola. Alla fine degli anni Cinquanta, quando l’isola si avviò al turismo e ospitò la Rassegna delle Attività Subacquee e Ustica divenne la capitale della pesca subacquea, la cernia, presente in gran numero nelle acque dell’isola, divenne protagonista come preda ricercata per le sue grandi dimensioni e trofeo ambito e ostentato per tutti i sub in gara. Quando l’isola si converti alla tutela del suo mare e divenne sede, nel 1986, della prima riserva marina d’Italia le cernie divennero oggetto di attenzione di ricercatori e ancora una volta protagoniste, stelle di prima luce nell’universo sommerso. Per studiare il loro comportamento venivano catturate, curate in apposite vasche, anestetizzate e sottoposte a intervento chirurgico per inserire nella cavità addominale un trasmettitore acustico per segnalarne i movimenti. La ricerca durata alcuni anni ha portato Ustica alla ribalta internazionale. (AV)
Cfr. Nicosia Angelo, Ustica nel 1959, in «Lettera» n. 1, 1999, pp. 16-19
Cfr. Lembo Giuseppe, A passeggio con le cernie di Ustica, in «Lettera» n. 1, 1999, pp. 12-15.
Cfr. Lembo Giuseppe, La cernia porta Ustica alla ribalta internazionale, in «Lettera» n. 11-12, 2002, pp. 37-40.
(NA_ 0002)
Grotta dell'Oro
Grotta dell'Oro
La grotta dell’Oro si apre nella costa di Tramontana tra il Cimitero e la Colombaia. È una caverna, ben più ampia di quella vicina del Parrinu, anch’essa scavata dai marosi in una breccia esplosiva con inclusi molti massi a spigoli vivi. La grotta ha un ingresso largo circa m 10 ; vi si accede in barca anche con risacca. Ha un solo ambiente che si sviluppa per circa 35 metri. I riflessi dorati delle rocce giustificano il toponimo.
La grotta è inserita nel Catasto Speleologico Siciliano al numero 408.
Cfr. Mannino Giovanni e Ailara Vito, Le Grotticelle. La Grotta d’ ‘u Parrinu e la Grotta dell’Oro, in «Lettera» n. 17-18, 2004, p. 57-60
Cfr. Mannino Giovanni e Ailara Vito, Le grotte di Ustica, ed. CSDU, Palermo, 2014, pp. 93-97
(NA_0003)
Fiore di lenticchia
Fiore di lenticchia
La lenticchia di Ustica (Lens culinaris Medik) è coltivata sull’isola sin dai tempi della colonizzazione dell’isola del 1763. Ne ricorda la coltivazione il naturalista Calcara (1842); ne decanta il gusto l’arciduca Luigi Salvatore d’Asburgo (1898): «molto piccole ma gustosissime e fave eccellenti»; ne ricorda il “valore sociale” come piatto dominante nella mensa popolare il Parroco Tranchina (1886): «La minuta lenticchia di Ustica un tempo era molto ricercata».
La semina si fa a dicembre a spaglio o a fila, cioè entro solchi alternati, eseguiti con aratro a chiodo trainato dall'asino. Alla sarchiatura (zappuliata), effettuata rigorosamente a mano, segue, prima della fioritura, con estrema cautela la scerbatura, ossia l’estirpazione di erbacce sfuggite alla sarchiatura. La raccolta si effettua a mano nelle sole ore mattutine, prima dell’alba, quando le piante con i baccelli quasi secchi sono ancora bagnate di rugiada. Le piante, essiccate al sole, vengono strasportate con la cutra e trebbiate nell’aia con metodo della pistata e della spagghiata. In questi ultimi tempi, con la promozione del prodotto nel mercato nazionale, la coltivazione è stata intensificata e si vanno introducendo strumenti meccanici sull’intero ciclo.
La lenticchia, un tempo coltivata come elemento di base dell’alimentazione locale, poi, nell’Ottocento, esportata in grande quantità sulle piazze di Palermo e di Napoli, ora, dopo il riconoscimento di area slowfood, ha conquistato il mercato nazionale e, in questo 2015, è finita, incredibile ma vero, nel menù dell’astronauta Samantha Cristoforetti. Foto di Bruno Campolo. (AV)
Longo Nicola, Longo Margherita, La Pistata delle lenticchie in «Lettera» n. 13-14, 2003, pp.26-35
Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, p. 29.
Calcara Pietro, Descrizione dell’isola di Ustica, in «Giornle Letterario», n. 229, Palermo, 1842, p. 49
Ludovico Salvatore d'Asburgo, Ustica, ristampa in lingua italiana, ed. Giada, Palermo, 1989, p. 94
(NA_0002)
Assiolo, Cuccareddu
Assiolo, Cuccareddu
L’assiolo (Otus scops) è individuato dagli Usticesi col nome Cuccareddu. È un piccolo rapace notturno, lungo di circa 20 cm, tarchiato con testa grande che, in posizione di riposo, si distingue per due minuscole orecchiette di piuma che lo rendono simile alla civetta. Di giorno si riposa in posizione immobile e ben riparata mimetizzandosi su rami di alberi o su ficodindia. Si nutre di cicale, cavallette, maggiolini, insetti, lombrichi. È uccello di passa, un tempo a Ustica abbondantissimo specie nella stagione autunnale (se ne cacciavano sino a 100 al giorno); veniva cacciato con cartucce caricate con ghiaia e crusca, ma anche con le mani; cucinato al sugo costituiva un piatto molto apprezzato degli isolani; ora è molto meno frequente a causa della sua diminuzione in Europa e non può più essere cacciato in quanto specie protetta. Foto E. Canale. (AV)
Cfr. Massa Bruno, Importanza dell’isola di Ustica per gli uccelli migratori, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9 Massa Bruno, The importance of the Island of Ustica for Migratory Birds, in «Lettera»n. 13-14, 2003, pp. 1-9
Cfr. Tranchina Giuseppe, L’isola di Ustica dal MDCCLX sino ai giorni nostri, parte II, Nozioni sulla storia naturale di Ustica, Palermo, 1886, pp. 11-12.
(NA_ 0001)